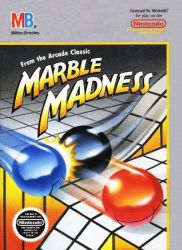
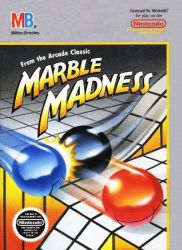
E dato che, spesso, quei titoli per una serie di motivi non si vedono più da lustri, ci ricordiamo qualche dettaglio in particolare. La musichetta ipnotica di Tetris, la tuta di Super Mario, la freccia di Link (Zelda)…
Bene, oggi parleremo di un arcade che ha fatto storia, legato indissolubilmente alla terza e quarta generazione di console.
Ma cominciamo dal principio.
Dopo il videogame crash del 1983 il pubblico non era più disposto a comprare cloni mediocri di quel che era già stato proposto in precedenza. Il déjà-vu non avrebbe funzionato. La crisi aveva messo davanti sviluppatori e publisher davanti alle loro responsabilità. Occorreva dunque focalizzarsi sul game-concept e presentare una creazione davvero originale per vendere.
Atari, software house storica dell’epoca e tra quelli che soffrirono di più la contrazione del mercato, raccolse la sfida. E nel 1984 decise di puntare sul lavoro di Mark Cerny, vero e proprio golden-boy dell’industry.
All’età di soli diciassette anni era entrato infatti nell’organico della casa americana. A quel tempo i team di sviluppo erano composti da pochi smanettoni, hacker reduci dai 70s’, ragazzi promettenti ed appassionati di architetture. Il professionismo era materia tutta da plasmare.
Ma proprio in questo contesto così in divenire e senza le regole del business system attuali forse riuscivano a nascere così tanti geni del settore.
Se il suo cognome non vi dice nulla, possono parlare i videogiochi che ha contribuito a realizzare, come Sonic The Hedgehog (SEGA è stata la sua casa per molti anni) e la serie di Crash Bandicoot. Attivo come consulente proprio nell’industry, nel 2004, tanto per far capire il valore del lavoro e della persone, ricevette il tributo alla carriera durante i Game Developers Awards Choice (una sorta di Oscar del videogioco), per aver saputo giostrarsi sempre con profitto dalla figura di mero sviluppatore a produttore esecutivo.
Un anno e mezzo più tardi dell’ingresso in Atari si propose nel ruolo di game-designer ed uscì l’idea alla base di Marble Madness. L’obiettivo del single player è quello di guidare la pallina attraverso una serie di ostacoli dettati dal percorso e da nemici in movimento senza essere intercettati e prima del tempo limite fissato per ogni livello.
Geniale nella sua semplicità perché, se vi ricordate, proponeva su schermo quel che era stato un gioco “arcade” ma fisico, nato nel legno ma decenni prima.
Dal punto di vista tecnico si fa apprezzare per molti motivi.
Le ambientazioni ricordano da vicino i percorsi delle macchine da corsa e quelli dati dalle simulazioni di golf.
Ma la grafica, l’uso in particolare dei “cubetti marmorei” e le illusioni visive dei saliscendi sono chiaramente ispirati dalle creazioni di Maurits Cornelis Escher geniale artista olandese in grado di catturare la bellezza dell’infinito e disegnare costruzioni fisicamente impossibili, paradossi dati dalla percezione dell’occhio umano.
La visuale scelte fu quella isometrica e le limitazioni della macchina diedero seguito a molti compromessi, che però non ne ostacolarono il successo commerciale.
Marble Madness fu il primo titolo ad usare l’innovativa piattaforma Atari System 1. La scelta fu dettata dalla possibilità di avere per la prima volta un’audio stereo nativo (grazie al chip FM Sound Yamaha) e soprattutto di poter sviluppare con il linguaggio C. Cerny e l’amico Bob Flanagan decisero di abbandonare l’Assembly in favore di una maggiore facilità nella programmazione del gioco.
Poter lavorare ad un più livello di astrazione portò inevitabilmente il team a sacrificare alcuni elementi tecnici. La frequenza operativa venne dimezzata, da 60 a 30Hz ed anche gli scenari, rispetto alle creazioni di Escher, estremamente semplificati.
Solitamente i percorsi seguivano questo iter di sviluppo: presi alcuni degli scenari proposti dal grafico olandese, ridotti all’osso (come il processo di decostruzione, raffigurante un toro, riproposto su tela da Picasso), non trasposti pixel per pixel ma memorizzati in array di determinate dimensioni, attraverso i più avanzati algoritmi di ray-tracing dell’epoca, venivano renderizzati per quel che sarebbero stati poi nella realtà fisica degli stage.
La longevità non era forse quella sperata da Atari che spinse per l’adozione di livelli extra ma il tempo di sviluppo si sarebbe allungato di molti mesi e quindi, alla fine, il team di concerto con la dirigenza decise di commercializzarlo appena i Beta-test fossero conclusi.
Nelle sale giochi americane fu subito un successo: centinaia di coin-op venivano distribuiti in lungo e in largo per il Paese, generando interesse anche nel settore dell’intrattenimento casalingo.
I porting, più o meno di valore, non si fecero attendere ed i possessori di Amiga, Game Boy, Mega Drive Nonché Spectrum e Personal Computer poterono godere del fascino di Marble Madness.
Io lo ricordo con piacere e dispiacere sul Nintendo 8 bit. La tipologia 1 shot-1 kill, tanto cara ad amanti del platform e shoot’em up, era una sfida impegnativa, ma la mancanza di una trackball sostituita dal D-Pad classico portava a volte una certa frustrazione nel superare i passaggi più impegnativi.
Restano però indimenticabili i ricordi di quella pallina che rotolava su e giù per lo schermo accompagnata dalle note frenetiche di Bradley Muller e Hal Canon, conferendo un altro tratto distintivo di uno dei giochi più belli e senza tempo che siano stati mai creati negli anni ’80.










